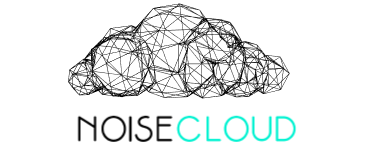Musica come forma di tempo: intervista a Federico Dragogna

Federico Dragogna, chitarra e penna dei Ministri, ha pubblicato il primo album da solista. Si intitola “Dove Nascere” ed è uscito il 5 maggio per l’etichetta Pioggia Rossa. Come mi ha detto nel flusso del discorso, è la prima volta che il suo nome e cognome appariranno nelle autoradio. L’intervista, che prevedeva 6 domande scritte su un foglio di carta, è deragliata dai binari tradizionali. Nel fuori programma che ne è conseguito, abbiamo parlato del suo rapporto con Genova e il rumore del mare, della necessità di scollinare i momenti difficili, del tempo che ci vuole per farlo. Della musica come forma di tempo ben speso per salvarci.
Qui la nostra chiacchierata.
Non riesco ad essere imparziale. Sono un tuo fan. Mi porto dietro tanti di quei lividi e quei poghi…
Be’, in questo album si poga poco.
Però si riflette tanto. Prima di tutto, spiegami questa virata un po’ fuori dal rock.
La mia anima di ascolto è un po’ lontana da rock. Il rock continuo ad analizzarlo e studiarlo quando lavoro coi miei soci (Divi e Michelino dei Ministri, ndr). Penso che il giorno che non dovessi più lavorare nella “questione Ministrica” – cosa che attualmente non è in programma – non andrei più in quella direzione. In realtà, ci sono un sacco di cose rock con le chitarre elettriche che mi interessano, come i Tame Impala.
I Tame Impala, effettivamente, non hanno un approccio classico al rock, con tutti quegli effetti psichedelici.
Ma guarda, è proprio una questione di linguaggio, di gesti. Non sono mai stato uno da “rock da motocicletta”. Per carità, anche in quel mondo ci sono un sacco di belle cose. Solo che non è da me. È proprio una questione di spirito: ho paura delle moto (mai guidato un motorino), delle cose su due ruote in generale. Tolta ovviamente la bici, che resta un atto di fede.
Altri mondi che ti hanno ispirato, oltre ai Tame Impala?
Damon Albarn. Ho tanto tanto ascoltato il suo ultimo album, “The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows”. “Dove Nascere”, nelle sonorità, assomiglia però al suo esordio da solista, “Everyday Robots”.
Che poi, in realtà, non sono un fanboy di Damon Albarn. Non sono un fanboy in generale. Magari più da piccolino di Queen, Battiato e De André. Quest’ultimo mi ha accompagnato per tutta la vita. Ma sono in generale poco fan come tipo di approccio. Quando un disco di un artista mi piace tanto, cerco di non andare ad ascoltare altre robe sue, per non farmi eccessivamente influenzare e tenermi in testa quell’album che più ha avuto impatto su di me.
Tra le altre cose che mi hanno ispirato, ho ascoltato tantissimo “Carrie & Lowell” di Sufjan Stevens. Rimanendo in Italia, Andrea Laszlo De Simone.
Quali sono stati i tuoi “dubbi” (per citare il tuo singolo) nel pubblicare il tuo primo disco da solista a 40 anni?
È interessante questa cosa dei 40 anni, perché è sempre stato un ritornello di mia madre, che mi avrebbe voluto vedere soltanto come scrittore. Mi diceva che i grandi libri si scrivono dopo i 40 anni. Forse già qualcuno l’aveva detto prima di lei, ma per me questa massima è sua.
In realtà, non ho mai avuto dubbi di fare questo passo. Da sempre ce l’ho in testa, ho sempre rimandato per vari motivi: tempistiche, opportunità, banalmente la pandemia. I dubbi, quindi, non erano se farlo, ma come farlo. Dubbi sulle sonorità o su quali pezzi inserire, considerato che ne avevo scritti molti di più. È curioso che, in concomitanza col fatto di aver deciso di farlo, c’è stata una serie di altri capitoli della mia vita, compreso il dove vivere, che si sono allineati tutti nello stesso momento, come un ingranaggio.
I dubbi contenuti nel singolo sono altri. In generale, posso dire che il dubbio sia il principale prodotto della mia coscienza.
A proposito del dove vivere e dove nascere, il disco è nato tra Milano e Genova. Mi racconti il tuo rapporto con Genova?
Una volta su un palco di Genova dissi: “un giorno verrò a vivere un pezzo di vita qua”. i genovesi se lo segnarono. Per me Genova ha davvero tante fascinazioni. Una di queste è che ha uno dei centri storici più poveri d’Italia, dove – davvero – convivono tutte le classi sociali. Non come altri posti in cui, se non te lo puoi permettere, il centro storico cerca di buttarti fuori in tutti i modi. E poi, a Genova, il destino mi è venuto a cercare. Ero già in qualche modo legato alla Liguria, ascoltando De André sin dall’infanzia.
Dicevo, il destino mi è venuto a cercare nelle vesti di Enrico Molteni dei Tre Allegri Ragazzi Morti (uno dei fondatori de La Tempesta), che un giorno mi chiamò e mi chiese se volessi produrre il disco di due svedesi, Kristal e Jonny Boy. Io dissi sì. Era un periodo in cui avevo il cuore spezzato, avrei detto sì anche se mia avessero chiesto di andare in bici fino in Mongolia. Mi disse anche che avremmo fatto la produzione a Genova al Greenfog Studio, insieme a Mattia Cominotto. Andai lì pronto per qualsiasi esperienza e io e Mattia diventammo amici letteralmente in un’ora. Tramite lui mi si aprì tutta Genova.
E dire che io ti ho sempre legato a Milano. Anche le sonorità del disco mi sembrano molto “metropolitane”. Qual è la prima immagine che associ all’album?
La prima immagine che ho è quella del regionale che mi porta a Genova (ride, ndr). Dici bene, io sono un animale cittadino. Anelo (come detto in “Scomparire il Rumore”) a terre altre, a silenzi, a posti dove scappo, sempre però partendo da una città, che per me resta uno spazio fondamentale. Ho bisogno di avere altri intorno a me, altri che stanno facendo cose. Genova è comunque una città, anche come spirito. Credo sia la sesta d’Italia per popolazione…
Confermo.
Ha anche perso un sacco di abitanti negli ultimi tempi.
Eh, vista l’età media, posso capire…
Ad ogni modo sono andato lì a scardinare le statistiche. Ma Genova si sente città dentro, come temperamento culturale. È anche molto autentica, non è diventata “turistica”, anche per via del fatto che ha un sacco di sbattimenti, a cominciare dal territorio. Mi piacciono gli sbattimenti, la fatica. Non riesco a rilassarmi se non ho fatto fatica prima. E poi, l’accoglienza che mi ha dato la città da “foresto” è stata incredibile, contro ogni luogo comune su Genova e i mugugni genovesi.

Cambiamo argomento e toglimi una curiosità. Il pezzo “Musica per aeroporti” a quale aeroporto è dedicata?
A quello di Dubai. Lì ebbi l’illuminazione. Ero di passaggio per andare in Laos e Cambogia. Sai quelle robe che fai con i voli low cost in cui aspetti 8 ore prima di prendere la coincidenza?
Hai dormito lì per terra nell’attesa?
Anche, ho pure dormito, tra l’altro davanti ad un negozio di Swaroski. Quel paradosso che hanno gli aeroporti.
Mica puoi farlo in via Montenapoleone.
Esatto. Di contro un aeroporto è costruito in modo tale che chi dorme per terra in città non riesce ad arrivarci. Un viandante può arrivare in una stazione, dormirci, ma è difficile che succeda in un aeroporto, che sta geograficamente lontano dallo centro urbano.
Girai su e giù per l’aeroporto di Dubai e non vi trovai nemmeno un libro. La cosa mi fece pensare qualcosa come “hey, è possibile!”. Penso a noi che ci facciamo le nostre idee di apocalissi culturali, senza veramente crederci.
Dovessi ripercorrere le canzoni del disco, qual è stata la prima che è nata?
“Scomparire il rumore”.
E a proposito di rumore, ci sono rumori che ci fanno scappare, ma anche altri che ci fanno tornare. Qual è un rumore bianco che ti piace?
Un po’ di provini del disco sono nati su delle spiagge liguri. Lì dentro c’è il banalissimo e classicissimo rumore del mare. Quello è universale e lo amo anche per le esperienze di campeggio libero che ho fatto. È davvero bellissimo addormentarsi sentendo il suono delle onde. Il cervello è una macchina che riesce a zittire alcuni rumori o farteli sentire come decide lui. È buffo come dormire davanti al mare significa anche dire “ma che cazzo di casino fa il mare!”. Tutto soggettivo. Tecnicamente, è il cervello che crea il suono.
In “Sei diventato uomo” parli di riti di iniziazione, di passaggi tra un prima o un dopo. Hai vissuto nella tua vita un tuo personale rito di passaggio?
Sì, c’è stato un momento. L’anno di “scollinamento” è stato il 2017, in cui ebbi il cuore spezzato, come detto poco fa. Però non fu soltanto una questione di cuore spezzato (per me era praticamente la prima volta). Insieme al cuore, venne giù un po’ tutto. Venne giù il me di prima che aveva già dato dei segnali di essere un po’ nella fase di declino dell’impero. Ma, come succede anche negli imperi, era anche un periodo di festa esagerata.
Lo sfarzo che nasconde il declino.
Sì, quelli furono 10 mesi di dolore e “muta”, come un serpente. Avevo 35 anni. Non che questo sia l’ultimo scollinamento. Non penso di essere diventato un uomo lì.
“Sei diventato uomo” è basato un po’ sull’espressione “che cosa vuol dire diventare un uomo?”, che magari è un po’ passé, ma ha molto a che fare, prima ancora che con la responsabilità, con il dolore, col nostro rapporto col dolore, su come gestirlo e come gestire tutti i dolori che ci aspettano. Dolori legati a separazioni, abbandoni, scomparse e assenze. Tutte cose che non ci vengono tanto anticipate e annunciate, soprattutto per come tendiamo a vivere oggi. Probabilmente, a inizio 900, la produzione culturale cercava di dire che prima o poi soffriremo; oggi non si parla mai di quello che verrà. Siamo una società molto adolescenziale, sicuramente come tono, ma anche come target, considerato che sono gli adolescenti e i giovani adulti a fare le nostre classifiche.
Anche “Non tornare adesso”, che parla del ricostruirsi dopo la fine di una relazione, si lega a questo concetto?
Era sempre quell’anno lì, il 2017. Ieri in un’intervista mi hanno detto “uh, ma come sei saggio! Se sempre stato così?” Io ho scritto questo pezzo perché non stavo riuscendo ad aspettare. È stata una lezione della vita che mi ha dato l’altra persona, che a un certo punto mi ha detto che dovevo scomparire e rimettermi in ordine. E poi forse ci saremmo rivisti.
La musica aiuta in questo processo di ricostruzione?
Che bella domanda… Guarda, questa storia, tutto questo 2017, ha avuto un happy ending, che perdura tuttora. È stato fondamentale per il mio equilibrio, forse anche per fare questo disco. C’è stata tanta musica, sia fatta che ascoltata. Sufjan Stevens l’ho acoltato proprio in quel periodo lì. Se tutti quei 10 mesi di merda fossero stati senza musica… Mioddio! Non so nemmeno come sarebbe passato il tempo. La musica di fatto è tempo. Se blocchi il tempo, scompare la musica. Quindi, da quel punto di vista, il fatto che mi servisse tempo per riordinare tutto e il fatto che il tempo sia musica, significa che la musica come forma di tempo è ciò preferisco.
Non potresti comunque fare quello che fai senza un principio di caos da riordinare.
Sul fatto che sotto il tappeto ci sia il caos, è letteralmente parte di come vedo il mondo. Non solo caos, ma anche cose irrisolvibili. Questo disco parla di diversi temi molto precisi, caotici nel senso di accettarne proprio la costituzione irrisolvibile: le migrazioni in “Dove nascere”, il paradosso della propria identità in “Lavorare è il mio secondo lavoro” o “Sentiti libero”, il problema dell’ansia in “Cascate”. La cosa che mi fa sorridere e arrabbiare è questa volontà velocissima di aver trovato la soluzione a tutto, come riporta oggi tutta quella letteratura motivational.
La favola del problem solver che risolve tutto in un attimo.
Se Internet dopodomani, grazie ad attentissimi filtri e ad una redenzione del popolo umano, diventasse una terra di solo bei pensieri, sparirebbe il male? Avremmo un incredibile autostima di noi stessi? Chiaramente no.

Parli di ansia in “Cascate”. Ti ritieni una persona ansiosa?
No, ma lo sono molte delle persone con cui ho vissuto. “Cascate” è un pezzo di osservazione sugli altri. Non sono mai stato ansioso, per fortuna. Anzi, per molti anni sono stato un po’ duro con le persone ansiose. Mi sembrava che dicendo di fare certe cose, dividere i problemi in piccoli comparti, bastasse a risolvere le cose. La paura del fallire l’ho vista come un sentimento che può mangiarti e consumarti. Ad un certo punto è preferibile la cascata, che è qualcosa che ti fa cadere o saltare, arriva come una scelta inevitabile e che ti cambia qualcosa nella vita. La musica, in questo senso, riesce ad essere un sedativo per l’ansia. Tante delle persone che conosco e soffrono d’ansia sono legate alla musica in maniera forte, spesso più forte di quanto ci sia legato io.
Cosa ci dobbiamo aspettare sulla presentazione live del disco?
A parte qualche data in cui suono da solo, sarà un live con band e sarà molto molto suonato. Non sono un fan del computer sul palco. Non ce la faccio. Molti pezzi saranno molto più simili alla versione studio di quanto pensassi. Merito della band: tre ragazzi bresciani, Emanuele Tosoni, Filippo Caretti e Andrea Ragnoli (che sta attualmente sta suonando con Maria Antonietta). Sarà un live con tanta musica, con tante code suonate.
Sarà difficile pensarti in un contesto un po’ più tranquillo.
Un po’ mi dimenerò comunque. Non sono un “dimenatore” che deve per forza dimenarsi. Niente scuola pop punk, della serie “hey ragazzi, in questo punto facciamo il saltino”. No, mai in vita mia. Io semplicemente quando suono se a un certo punto mi sto gasando, mi gaso e basta. Quindi, in realtà, ci sono un po’ di pezzi dell’album in cui mi dimeno. La coda di “Sei diventato un uomo” esplode dal vivo, mentre sul disco no.
Penso che ci vedremo al MI AMI allora. In bocca al lupo!
Grazie! Buon lavoro e buona fortuna anche a te!